Cocco e tè
di Laura Ricci, da “Insopprimibili vizi”, AMEdizioni Marotta 2004, non più in commercio
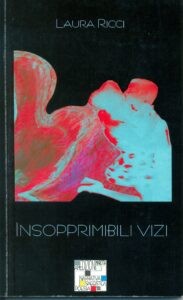 Ho annegato la tristezza in una tazza di tè – il mio tè – ma basta un po’ di tè per annegare la tristezza?
Ho annegato la tristezza in una tazza di tè – il mio tè – ma basta un po’ di tè per annegare la tristezza?
Tutto è cominciato per un tè, fare un buon tè non è facile.
Devi portare l’acqua, meglio se non troppo dura, all’ebollizione, ma essere così abile da spegnerla un attimo prima. E poi attenzione, proibiti i filtri, e mai far galleggiare nel bollitore le foglioline. È l’acqua che deve andare alle foglie, non le foglie all’acqua.
La teiera devi prenderla rigorosamente di porcellana, meglio se chiara – appena ambrata o pastello o candida – porre le foglie nel fondo e versarvi sopra l’acqua. E, di porcellana leggera, devono essere anche le tazze: Royal Albert, possibilmente, o Bavaria, al massimo. Alla ceramica non pensarci proprio; il tuo tè, anche fosse il migliore del pianeta, e la ceramica la più graziosa, acquisterebbe un sapore orrendo: è un fatto chimico, non si scampa.
Le mie, di tazze, erano Royal Albert. Candide fragili tazze dal rigo d’oro sottile, ornate ma non troppo di piccole rose canine, le stesse del piattino; i pezzi non infranti del mio matrimonio sbriciolato da tempo – triturato da non far quasi più male – il primo regalo di nozze. Sapevo già come si fa un buon tè, e le avevo amate, quanto amate quelle tazze. Non per il lusso, per la porcellana buona; e per il disegno delicato.
Ho esitato, quel giorno, prima di metterle sul vecchio tavolo. Per un tipo come lui, così immediato e informale, forse troppo preziose; per un tipo come me, così infrattivo sotto l’ apparenza quieta, forse un po’ mendaci; per un tè all’aperto, in un giardino di campagna non molto curato, forse inappropriate. Perché poi, come non usare cucchiaini d’argento con tazze di tal sorta?
Ma ha prevalso la scientificità, quel fatto chimico della porcellana: gli avevo promesso il miglior tè del circondario, il tè dei tè, quello che nessun Caffè, nessuna Sala, sia pure eccellente, saprebbe servire; e poi, per il tè, non avevo che quelle tazze.
Dovevo offrirgli un carnalissimo tè – così l’avevo chiamato – pretesto per conoscerci meglio, variazione del cappuccino del primo incontro. Non sono donna da coca cola o da aranciata. Dovevo offrirgli un carnalissimo tè – carnale nel senso di reale, quotidiano – per smussare il pathos di certe parole scritte, pericolosamente intense che ci scambiavamo; per parlare in prosa; per issare, chissà perché, l’argine, forse meno intrigante, della presenza. Ero sola – il mio matrimonio inutile alle vacanze separate – ma di certo non volevo sedurlo. Una donna non più giovanissima che tenta un giovane uomo… No, esattamente il contrario: un carnalissimo tè per affermare nient’altro che una profonda amicizia.
Non è andata esattamente così, non come avevo pensato. E l’amicizia profonda forse non c’è, quando è profonda è amore. O l’amore è l’unica forma di vera abissale amicizia. Vacci a capire, chissà.
Il tè, quel giorno, lui non l’ha finito, anzi, ne ha bevuto pochissimo. E io, che bene non lo conoscevo ancora, ho pensato che non gli fosse piaciuto per via del latte. Perché si sa, da noi quasi tutti prendono il tè con il limone, ma con il limone tutti i tè sono uguali, l’acido citrico li uccide. Se vuoi conoscere il gusto vero del tè, sperimentare le varie miscele, devi metterci solo un goccino di latte; o anche niente se è molto aromatico.
Il tè cattivo, quello del bar, lui lo finisce. Ma quello buono, quello da me – da me che, con le mie tazze da tè, senza più i cocci del matrimonio, da quella casa del tè carnalissimo me ne sono andata – lui non lo finisce mai. E non è una questione di latte, è una questione d’amore. Perché mi parla, mi parla, mi parla, tanto e anche più di quel pomeriggio di luglio tra i merli in canto, le vespe gialle e la seconda fioritura del gelsomino. Mi parla finché non lo bacio. E se lo bacio mi bacia, mi bacia, mi bacia. E il tè, quello buono, quello perfetto, quello nella tazza Royal Albert – e chissà se lui l’ha mai vista la bellezza preziosa di quella tazza – resta lì e si fredda.
Perché quel giorno, quando se ne è andato senza finire il suo tè, per salutare mi ha preso le mani. E nelle mani ha sentito il mio cuore che ricominciava a battere.
Anche quel giorno il mio amore è arrivato in ritardo; li ha annunciati, i suoi contrattempi, con varie telefonate. Per un poco si è perso nel mio tè – l’ora non c’era più – pochi sorsi; nei miei occhi si è perso – o chissà, si è ritrovato – nelle mie orecchie, nell’odore del gelsomino, nel ronzio delle vespe, nel sorriso o nelle parole della mia bocca. E poi, anche quel giorno, come una raffica, stringendomi le mani, dopo tanta dolcezza improvvisamente è fuggito.
Un uomo giovane ha sempre molto da fare, migliaia, milioni, miliardi di cose da fare, dovevo prevederlo. Ma da quel giorno, ogni previsione mi è sfuggita.
I ritardi, gli impegni, i contrattempi, i rinvii: in queste cose, suo malgrado il mio amore è specialista. Il tempo passa, e lui ti manca fino al morso allo stomaco, fino al groppo alla gola, fino a farti venire il mal di testa.
Ho annegato la mancanza in una tazza di tè, la mia solita tazza Royal Albert, ma basta?
Non basta; ma per quel tè carnalissimo, per quelle mani, per quel cuore che ha ricominciato a battere – e forte, così forte come non ha battuto mai – sono disposta a soffrire questo e altro.
Dei pasticcini di quel giorno, invece, non mi ricordo. Forse non c’erano, forse erano dei biscotti inglesi alla menta. Comunque, i miei preferiti sono al cocco.