di Laura Ricci dal n.2 della rivista “Letture”, il Ponte Rosso, Trieste, aprile 2020
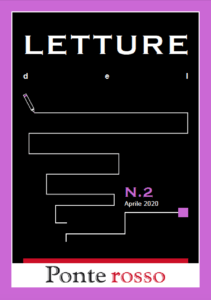 Erano due i luoghi al mondo che amava di più, quelli di cui sentiva scorrere la linfa nel midollo, sebbene non avessero nulla a che fare, né l’uno né l’altro, con quelle che comunemente si definiscono «le proprie radici». Ma lei, le radici, non le avvertiva proprio, non le aveva mai affondate in nessun terreno; da sempre si sentiva, piuttosto, una sradicata. Una che da un luogo ne insegue sempre un altro, proiettata a un altrove da cui slanciarsi a nuovi altrove. Incessantemente, ma con calma, con previdenza quasi, senza rompere la testa o bruciare le ali: una marcia assetata e caparbia, ma sensata.
Erano due i luoghi al mondo che amava di più, quelli di cui sentiva scorrere la linfa nel midollo, sebbene non avessero nulla a che fare, né l’uno né l’altro, con quelle che comunemente si definiscono «le proprie radici». Ma lei, le radici, non le avvertiva proprio, non le aveva mai affondate in nessun terreno; da sempre si sentiva, piuttosto, una sradicata. Una che da un luogo ne insegue sempre un altro, proiettata a un altrove da cui slanciarsi a nuovi altrove. Incessantemente, ma con calma, con previdenza quasi, senza rompere la testa o bruciare le ali: una marcia assetata e caparbia, ma sensata.
Erano due, comunque, i luoghi fulcro della sua vita, quelli verso i quali sarebbe costantemente ritornata, quelli per cui provava nostalgia o, per meglio dire, un indecifrabile hüzün: la piazza di Eminönü a Istanbul e, a Trieste, il molo Audace. Erano stati, per lei, l’uno la conseguenza dell’altro: combinazioni di certo diverse, ma con elementi comuni. A Istanbul Maura c’era andata per sfidare sé stessa e la vita, per provare a non morire. E a Trieste invece, una volta rinata, per continuare a vivere. Avrebbe dovuto andarci, a Istanbul, con quel suo grande perduto giovane amore, anche se già sentiva che qualcosa stava cambiando e che forse, a Istanbul, non avrebbero fatto in tempo ad andare insieme.
È bello amare un uomo giovane, soprattutto se si ha una certa età, soprattutto se prima di incontrarlo si pensava di aver chiuso con l’amore. Anche se ogni tanto ci si dice, pur se l’amore è grandissimo, che forse prima o poi, proprio perché è giovane, lui si innamorerà di nuovo di qualcun’altra e ci lascerà.
Era estate, fine giugno quando si erano innamorati, come a lei sempre accadeva «a prima vista». Quando almeno lei si era innamorata davvero e perdutamente, immersa in quel sentimento particolare e unico che, quando lo si prova e persino quando non lo si prova più ma per qualche ragione lo si ricorda, sembra di vivere una sola volta nella vita. Pur se un’altra, sicuramente, ne verrà. Il sole batteva forte sulle pietre ambrate della sua piccola città, rendendo tutto stupendamente caldo e azzurro: in quel piccolo mondo, in quella stretta provincia, possibile che qualcosa di tanto enorme stesse accadendo, azzurramente, proprio a lei? Non aveva resistito, anche se lui era tanto più giovane. La vita non può essere fermata, si era detta, e poi, forse, la colpa era del sole… Si era andata a rileggere, per conferma, un passaggio di Janette Winterson che le capitava di rimuginare spesso, quasi fosse stato, anche in tempi insospettabili, una premonizione: “È vero che nei giorni di sole siamo felici. È vero perché il sole sulle palpebre produce mutamenti chimici nel corpo. Il sole rimpicciolisce inoltre le pupille a punture di spillo, riducendo l’afflusso di luce. Quando non vediamo quasi nulla è più probabile che c’innamoriamo. Niente è più frequente in estate dell’amore”.
Tuttavia non era stato, il loro, un fuoco di paglia, un’avventura delle vacanze. Colleghi di lavoro, quasi sempre vicini, erano stati insieme tredici anni. Lei, donna indipendente e abituata a vivere sola, mai era stata, nella vita, tanto piacevolmente protetta e viziata. Si era chiesta per qualche tempo se tutta quella felicità sarebbe durata. Poi non se l’era chiesto più – ci si abitua persino alla felicità – le sembrava che quello stato di grazia dovesse durare all’infinito.
A Istanbul, dunque, sarebbero dovuti andare: perché era quello – Istanbul – avevano sempre pensato, il loro luogo: ponte, frontiera, crocevia marittimo, incrocio di culture, megalopoli di contrasti. E invece, lui, si era di nuovo innamorato… Ti devo tutto, le aveva detto in una delle ultime conversazioni, la fiducia nelle mie capacità, la riuscita delle mie ambizioni, il successo; ero un ragazzo, mi hai aiutato a diventare un uomo, mi hai insegnato la libertà, mi hai insegnato ad amare. Già, così bene che si era di nuovo innamorato. Non aveva avuto neanche il coraggio di dirglielo, aveva dovuto scoprirlo lei. Dei tredici anni passati insieme, l’ultimo, per quel piccolo verme di disamore che scavava, era stato subdolo, lancinante, tortuoso. Discorsi, gesti, accortezze, da qualche tempo tutto in lui era cambiato; e l’amore, anche l’amore – il sesso – era più breve, distratto, silenzioso. La vita non può essere fermata, e a Maura non era difficile immaginare che si fosse innamorato di un’altra. Non le diceva nulla, ma si appartava, era sfuggente, evasivo. La terribile domanda a un certo punto l’aveva fatta lei. Ti sei innamorato di un’altra? Sì…, aveva risposto lui con un filo di voce, e come se quella domanda la aspettasse da molto tempo.
Le stelle possono cadere, il sole spegnersi, il mare defluire, la terra inaridire per chi è trafitta dai tradimenti d’amore. Non sapeva se era stato peggio quel momento o il vuoto che era seguito quando, dall’oggi al domani, non l’aveva né visto né sentito più. Aveva dovuto lasciare anche il lavoro infatti, perché era troppo doloroso averlo sempre sotto gli occhi e vederlo così perdutamente innamorato di un’altra. Da troppo a niente, come se nulla fosse mai stato, incenerita da una folgore di cui per lungo tempo non aveva supposto la possibilità.
Aveva comprato, sperando di guarire, un piccolo Trattato di culinaria per donne tristi. Non un gran tomo, un libricino di un centinaio di pagine, da leggere in poco tempo per rimettersi in fretta. Quello che le aveva aperto il cuore alla speranza era stato un capitoletto sulla durata del dolore, in cui la ricetta non era data per placarlo, ma per farlo sguazzare liberamente. “Non risparmiare le lacrime – consigliava Héctor Abad Faciolince, l’arguto autore di quel prezioso talismano – sguazza nel dolore con tanta intensità come prima nel piacere. Perché c’è una regola ineluttabile che, adesso che la sentirai, ti renderà ancora più triste: col passare del tempo non soffrirai più tanto; vorrai soffrire come prima e non ne sarai capace. È impossibile soffrire e soffrire per molto tempo. Anche lui, lui, finirai per dimenticarlo. Costi quel che costi e accada quel che accada: se dopo trentasei mesi continui a soffrire come adesso, non soffrirai per lui, soffrirai per il senso di colpa di non continuare a soffrire. Nonostante fosse senza limiti l’amore che provavi, il dolore è avaro, dura meno”.
Seguendo quel consiglio si era immersa nel dolore senza ritegno: aveva pianto e singhiozzato, sguazzato nella costrizione del cuore, dello stomaco, del cervello, contratto tendini e muscoli, perso completamente, pur senza dimagrire, l’appetito. L’esagerazione era stata tale che non c’erano voluti, per lei, trentasei mesi, ne erano bastati, anche grazie a Istanbul, molti di meno. Perché a Istanbul, nonostante la disperazione e lo sgomento, sebbene di nuovo sola e proprio perché sola, c’era andata comunque. Per dimostrare a sé stessa che poteva continuare a vivere.
“La bellezza del panorama è nella sua tristezza”, aveva scritto Orhan Pamuk della sua Istanbul riprendendo un pensiero di Ahmet Rasim. Dopo ripetuti soggiorni nella città, dove grazie alle amicizie intavolate aveva vissuto da abitante e non da turista, mai definizione le era sembrata più calzante e giusta. Ed era proprio quella «tristezza», quella luce soffusa e mai sfacciata del Bosforo ad averla guarita. L’azzurro intenso dei tempi del suo innamoramento non avrebbe potuto sopportarlo, e Istanbul invece si tingeva di azzurro pastello, polvere, avio, acquamarina, di quel celeste lieve e grigiastro del Corno d’Oro che al tramonto si accendeva di giallo caldo. Quella discreta temperata tavolozza spargeva pagliuzze balsamiche sul suo dolore. E le lunghe soste a Eminönü, mentre osservava sfilare le navi sotto il ponte del Bosforo e più vicino i battelli, stridere e svolazzare i gabbiani, formicolare tra le moschee e i carrettini degli ambulanti di mais e di simit la grande piazza, erano state le bende per far assorbire unguenti alle sue ferite.
Quella che aveva amato, lontano dalle facili cartoline di Sultanahmet, di Topkapi e del festival primaverile dei tulipani – originari, aveva scoperto, della Turchia e non dell’Olanda – era stata soprattutto la città invernale, ancora più soffice e ovattata. Quando i turisti non invadono pesantemente la vita locale; gli arabi e le arabe dal volto completamente coperto, che tanto contrariano le turche quando le si scambia per loro, scompaiono; il lamento dei gabbiani si addolora e sale e, tra le nebbie o nella foschia della pioggia, le sirene di qualche nave che solca lo stretto sembrano modulare lo struggimento di tutti gli addii e di tutte le separazioni del mondo.
Com’era piccolo, ristretto, chiuso in un corpo impermeabile quel suo dolore, pensava Maura guardando dalla banchina verso il ponte e il quartiere di Galata. Quell’antico assembramento, sormontato dalla vecchia torre e accerchiato dagli edifici moderni che ne rendevano ancora più affascinante la scoperta, la avviluppava nelle ascendenze italiche di Istanbul, quando nella latina Costantinopoli l’imperatore bizantino Michele VIII Paleologo, riconquistando nel 1261 la capitale caduta in mano ai crociati, era stato costretto ad allearsi con i Genovesi contro la potente Repubblica della Serenissima e aveva concesso loro di costruire sull’area di Galata una città, una vera e propria colonia indipendente con un governatore designato dai senatori di Genova. I Genovesi avevano allargato e cinto di mura la zona loro assegnata, finché nel 1453, dopo la conquista ottomana, le mura erano state distrutte e il quartiere era diventato il cuore europeo della città. Naviganti, artigiani, trafficanti vivevano lì in una fervida mescolanza di popoli e di culture, con i Greci che si distinguevano nella gestione di animate taverne, e gli Armeni e gli Ebrei nei commerci, negli affari e nella circolazione bancaria dei capitali.
Quando, lasciando la banchina verso Galata, si inoltrava nella grande piazza di Eminönü, Maura sentiva espandersi ulteriormente un benefico senso di relatività. Di certo né lei né il suo dolore erano l’ombelico del mondo, c’erano così tante vite, così tante occupazioni a formicolare, e la vista di svettanti minareti e di ben tre moschee – la Moschea Nuova, quella di Rüstem Paşa e sullo sfondo quella di Solimano – amplificava ancora di più il pensiero e lo spazio, traghettandoli dal quotidiano al divino. Per non parlare del Mercato Egiziano, quel favoloso Misir Çarşisi che si apriva proprio sulla piazza, e si inoltrava ai suoi margini in un intrico di strade e di mercanzie. Vi si era ripetutamente e volontariamente persa, tra i colori, gli odori, le voci, i sapori, i rumori di quel celebre regno delle spezie, e lì aveva gustato più volte il miglior börek di Istanbul.
Com’era esiguo, ristretto, chiuso in un corpo impermeabile quel suo dolore, pensava Maura, frastornata e travolta da quel diverso imponente brulichio del mondo. Bisognava aprire i pori, misurare la sua esistenza minima e privilegiata di piccola occidentale con il gorgogliare di un mondo altro e sterminato.
Pian piano del dolore quasi non si era ricordata più, ma la felicità non l’aveva cancellata. Quanto era stata grande e preziosa l’aveva calcolato grazie al Museo dell’Innocenza di Orhan Pamuk. In otto anni, Kemal conteggia millecinquecentonovantatré sere di felicità trascorse, estatico, alla tavola della sua ormai inafferrabile Füsün. Lei, in tredici, tolte le domeniche e le poche separazioni, poteva valutare circa tremilaseicentosettantanove giorni passati con il suo perduto amato. Come Kemal, poteva dire di aver avuto una vita felice ma, diversamente da lui, pur non dimenticandola non l’avrebbe di certo incapsulata in un museo.
Con la forza e l’entusiasmo di un nuovo innamoramento spaziale e culturale, la sua esperienza a Istanbul era durata dal settembre 2014 al maggio 2015. Specialmente a primavera, durante la campagna elettorale che in giugno avrebbe visto l’AKP di Recep Tayyip Erdoğan perdere la maggioranza assoluta in Parlamento e l’HDP filo curdo entrarvi con il tredici per cento dei voti e ben ottanta seggi, la città era ovunque in fermento. Gioioso e giustamente speranzoso l’HDP inscenava girotondi colorati nei luoghi più animati della città, a Eminönü praticamente ogni giorno. La Turchia sembrava finalmente avviata verso una democrazia matura, pur se così non sarebbe stato. Gruppi di iraniane benestanti volteggiavano, sorridenti e filiformi nei neri chador, lungo il Bosforo sotto i giardini di Emirgân, e tra il tripudio dei tulipani del parco le donne turche, molto meno uniformi, passeggiavano in caftano o in minigonna o, bardate degli abiti tradizionali, punteggiavano i prati dei loro déjeuners sur l’herbe. Ma le siriane e le irachene, profughe di guerra, mendicavano con i loro bambini quasi a ogni uscita di metropolitana. Anche quel brulicare di ambulanti – che a ore diverse occupavano a turno le vie prossime a piazza Taksim con i loro poveri prodotti e la loro cortesia dimessa – parlava di un mondo ben lontano dai consumi dell’Occidente. Che non mancavano a Istanbul, no, soprattutto nei nuovi quartieri, ma che erano palesemente per ricchi e per stranieri, o per gli investitori che da molti luoghi dell’Europa e del mondo trovavano lì terreno fertile per le succursali e la materia prima dei loro affari.
Era tornata nella sua piccola città quasi guarita, convinta che avrebbe riguadagnato il Bosforo l’anno successivo. Il mal d’amore era sfumato, pur se qualche acuta spina, magari per un’improvvisa epifania, si faceva talvolta sentire. Ma era subentrato l’aculeo nuovo di un sottile hüzün: quella tristezza sublime, diversa sia dalla nostalgia sia dalla saudade, che di una mancanza fa un pungolo per trasformarla in un itinerario di elevazione. E l’hüzün la spingeva non a cercare un’impossibile sostituzione, ma quanto meno un’ulteriore esperienza di frontiera. Tanto più che a Istanbul, dopo l’ambiguo colpo di stato del 15 luglio 2016 e la svolta autoritaria di Erdoğan, non aveva voluto più tornare.
Dove poteva andare, si chiedeva già in estate, dove respirare quel clima particolare intriso della nostalgia di un grande passato? E il mare, si diceva, anche il mare doveva esserci nella nuova frontiera, perché di tutti gli orizzonti terreni almeno per lei quello marino era il più reiterato e inarrivabile, e per questo il più inseguito e desiderato.
Ma a Trieste, a Trieste! Devo andare semplicemente a Trieste! Molto meno lontano di quanto avrei creduto, perché non ci ho pensato prima?, si era detta un giorno rimettendo a posto i libri della sua biblioteca. I più attuali – il sempre amato Magris, Tomizza, Marisa Madieri, Rumiz, qualcosa di Prenz, qualcosa di Covacich – erano negli scaffali più a portata di mano; ma i classici, quelli dei tempi dell’università, se ne stavano impolverati nei piani più alti in vecchie edizioni in lire. Slataper, Svevo, Stuparich, Quarantotti Gambini… Bisognava rileggerli, alcuni ricomprarli in qualche edizione critica più aggiornata. Saba no, il suo canzoniere era nella piccola teca girevole dei libri sacri, quelli che leggeva e rileggeva continuamente. Era impegnativo un viaggio a Trieste, dove era stata troppo frettolosamente in gioventù di passaggio verso la ex Jugoslavia; pur se meno lontano di altri nello spazio, imponeva un ripasso e nuovi studi. Non immaginava, in quel momento, che molti altri testi si sarebbero aggiunti e che quella della letteratura triestina sarebbe diventata, nella sua libreria, una sezione ben più contemporanea e fornita. Trieste letterariamente non è una città, avrebbe pensato di lì a qualche mese, è grande e variegata quanto una nazione.
Tornata a fine maggio dalla Turchia, era partita verso Trieste già in settembre: contava di esplorarla almeno per una settimana, per poi proseguire verso Abbazia e Fiume, luoghi che in quel viaggio giovanile, tagliando per Postumia e Plitvice, aveva saltato. In realtà, soggiogata dall’atmosfera della città, si era fermata qualche giorno anche al ritorno. Si era documentata rispolverando letture letterarie e storiche, vi aveva aggiunto il sempre chiaro denso lavoro di Magris e Ara, la Trieste sottosopra di Covacich, la superclassica guida del Touring e quella ben più sagace e alternativa del Routard, e naturalmente aveva navigato attraverso un’infinità di siti internet. Come sempre, tuttavia, non aveva voluto conoscere tutto quello che avrebbe potuto avere a disposizione, un po’ perché risultava impossibile rispetto a una tale immensa complicata realtà sociale e storico-letteraria, un po’ perché voleva raccogliere impressioni da approfondire in un secondo momento. Il libro di Jan Morris, per esempio, il cui titolo la intrigava terribilmente – Trieste. O del nessun luogo – lo aveva volutamente lasciato da parte, perché prima di leggerlo voleva capire quale effetto, quel nessun luogo, avrebbe esercitato su di lei. E poi lei, senza trascurare i luoghi del turismo ufficiale – che però le piaceva esplorare a dosi contenute – amava anche bighellonare, sostare nei caffè, andare per viuzze e giardini, sedersi su cigli di fortuna e sulle panchine per osservare le persone e la vita quotidiana, scoprire e gustare i cibi locali che lì, grazie agli Asburgo e ai territori del passato impero, al Carso, al mare e ai suoi traffici, erano quanto mai numerosi e differenziati. Si era avvicinata a molti luoghi e a molte atmosfere in quel primo viaggio, ma aveva tralasciato tanti altri spazi e tanti aspetti su cui tornare. Perché di certo sarebbe tornata: in pochi giorni – a prima vista quasi – Trieste l’aveva già stregata.
Dalla sua piccola città il lento intercity che non richiedeva nessun cambio ma del quale, nonostante fosse una viaggiatrice, non si era mai resa conto, le era sembrato subito di buon augurio, e nel tempo, nei ripetuti vai-e-vieni, si sarebbe divertita a pensare che viaggiasse, sì, per una variegata moltitudine che saliva e scendeva alle innumerevoli fermate, ma per quasi l’intero tratto appositamente per lei. Le piaceva moltissimo, inoltre, che arrivasse in una stazione del tipo «Trieste centrale ultima fermata»: aveva sempre amato le stazioni per così dire «terminali», soprattutto quelle dove c’è una sola uscita e non ci sono né sottopassaggi né ascensori né scale; poche in realtà, ma Trieste era proprio tra quelle. Le era piaciuto che ad accoglierla, in piazza della Libertà – ma che bel nome – ci fosse quel maestoso monumento Liberty a Elisabetta d’Austria. Snella e bellissima, ma più grecizzante e robusta di quanto in realtà doveva essere, in quel bronzo Elisabetta era effigiata come Maura l’aveva sempre immaginata. Se la raffigurava infatti, guardando più alle poche foto reali che ai molti film e ai ritratti agiografici, inquieta, triste ma talvolta incline a qualche eccessiva risata nervosa, prigioniera della taglia trentotto e ossessionata dalla bellezza come tante ragazze di oggi, ribelle sotto i cinque chili della massa dei capelli, repressa dentro la stretta dei busti e delle trine, atleta e viaggiatrice indefessa per sfuggire alla pesantezza di un impero severo e rigoroso, assillata dalle tare ereditarie e dalle tragedie familiari della sua stirpe – la misteriosa morte dell’amato cugino Ludwig, il suicidio del figlio Rodolfo a Mayerling – lei stessa incalzata da quel colpo di lima dell’anarchico Lucheni che, in poco più di un’ora, le avrebbe tolto la vita sul lungolago di Ginevra. Maura avrebbe presto appreso che quel bel monumento Liberty – con la figura dell’imperatrice in bronzo, e un’allegoria delle arti e della natura e l’omaggio del popolo alla sovrana in marmo di Carrara – dovuto a Franz Seifert e inaugurato il 15 dicembre del 1912, dopo la caduta dell’impero asburgico e il passaggio di Trieste all’Italia era stato smembrato nel 1921 e riposto in un magazzino di Miramare. Solo nell’ottobre del 1997, in virtù della risistemazione della piazza, vi era stato ricollocato.
Ma più dell’infelice e problematica Sissi, a interessarla era la figura dell’imperatrice Maria Teresa. Le sembrava oltremodo significativo e bello che Trieste dovesse la sua crescita e gran parte della sua conformazione urbanistica a una donna, e in questo caso a una donna di potere di grande lungimiranza e intelligenza. Sì, Maria Teresa aveva raccolto la politica avviata dal padre Carlo VI, che già nel 1719 aveva proclamato il porto franco, ma era lei che di quell’editto aveva ampliato e realizzato le grandiose opportunità. La Trieste multietnica e multiculturale dell’oggi, che tanto l’attirava e l’affascinava, si doveva, almeno ai suoi prodromi, a quell’avveduta sovrana. Subentrata al padre, l’imperatrice aveva fatto abbattere le mura, bonificare le saline su cui erano sorti i magazzini, i bei palazzi del Borgo Teresiano e i moli del porto, realizzare il Canale e la piazza Grande, mentre per le facilitazioni commerciali e le franchigie Trieste attraeva mercanti, imprenditori e gente in cerca di fortuna di varie nazionalità. Con un rapido ed effervescente sviluppo, in breve tempo era diventata la terza città dell’impero austroungarico e, dai quattromila abitanti di fine Seicento, era passata ai circa duecentomila di fine Ottocento. Grazie ai traffici, ai commerci e alle vicende politiche legate alla rivoluzione napoleonica e alla restaurazione, nella fiorente tollerante città erano arrivati aristocratici illustri e uno sciame di popoli in cerca di lavoro e di una vita dignitosa: accanto agli italiani, ai tedeschi e agli sloveni – gli autoctoni di quell’impero che a Trieste pubblicava editti e ordinanze nelle loro tre lingue – si addensavano ebrei, armeni, sefarditi, polacchi, serbi, ungheresi, croati, montenegrini, albanesi, turchi, svizzeri, inglesi, dalmati e istriani. Tra tante fiorenti attività erano nate le Assicurazioni Generali e la gloriosa compagnia di navigazione del Lloyd Triestino. E accanto a tutto quel fermento portuale e commerciale, quello culturale non era certo da meno. La musica nelle case signorili e al teatro comunale nel 1901 intitolato a Verdi – con Toscanini, Martucci, Mahler – gli scrittori, i filosofi, gli intellettuali nei salotti e nei caffè – il Tommaseo, il Tergesteo, gli Specchi, il Torinese, il San Marco, la Stella Polare, la pasticceria Pirona – senza steccati tra gli incompresi della borghesia agiata, come Svevo, e gli outsider come Joyce; con Marinetti a presentare al Politeama Rossetti l’avvento del Futurismo e i randagi come il pittore Timmel, gli introversi come Saba, i solitari come Giotti; con la grande questione irredentista e l’animata dialettica delle opinioni in proposito.
Che meraviglia doveva essere Trieste a fine Ottocento e nei primi anni del Novecento, pensava Maura, proprio come si percepiva nei primi capitoli de Le quattro ragazze Wieselberger di Fausta Cialente, in quella descrizione “del folto passeggio quotidiano dell’epoca” in cui, oltre alle tolette eleganti dei ricchi borghesi e alle sgargianti divise degli ufficiali della marina, si vedeva ogni etnia vestire i suoi costumi, in quel mix di convivenza e tolleranza che aveva portato, anche nel culto, alla presenza della sinagoga e di chiese ortodosse accanto a quelle cattoliche. Che spettacolo doveva essere il passeggio sulle Rive, dove passava anche il treno che collegava Barcola a Campo Marzio allora, e che incanto le partenze dal porto e, dopo la prima guerra mondiale, quelle non meno emozionanti con il Simplon Orient Express. Proprio quello che avrebbe fatto capolinea nella stazione di Sirkeci a Istanbul, in quel quartiere di Eminönü a lei tanto caro. Tutto stupendo doveva essere stato, nonostante i sussulti, gli attentati, i patiboli dell’inquieto e vigoroso irredentismo locale. Almeno fino a quel tragico attentato di Sarajevo all’arciduca Francesco Ferdinando e alla moglie Sofia, fino allo sbarco delle salme proprio a Trieste e a quel corteo funebre triste e pomposo che avrebbe segnato, con l’imminente dichiarazione di guerra dell’impero austroungarico al regno di Serbia, l’inizio della Grande Guerra e la fine di ogni Belle Époque.
C’era un filo forse per alcuni invisibile che, ben oltre l’Orient Express e i traffici marittimi, legava Trieste a Istanbul. Invisibile, ma non per lei: vicende storiche complesse e travagliate, il veloce sviluppo urbano dovuto al sopraggiungere di numerosi strati sociali e di molte etnie, i fasti del passato imperiale e una tormentata mutazione politica talvolta mal digerita – l’occidentalizzazione spinta per la Turchia, la sospirata ma per certi versi deludente italianità per Trieste – e quell’anima picaresca di quel lembo azzurro e ventoso di Adriatico, troppo spesso soffocata dalla più scontata icona di crogiolo della Mitteleuropa, che specie nella contemporaneità, ma in fondo da sempre, ne faceva non solo una città organizzata e rigorosa di stampo asburgico, ma un luogo affabile e disinvolto, dedito alle relazioni e al sano piacere come è proprio dei popoli mediterranei. “Il continente mitteleuropeo è analitico, il mare è epico; – aveva scritto Claudio Magris in Danubio– sulle rotte di quest’ultimo si impara a liberarsi dell’ansia di Kyselak, smanioso di riconfermare continuamente la propria identità”. E Trieste di quell’ansia, grazie al mare, si era liberata, perché il mare “è l’abbandono al nuovo e all’ignoto”, è “affrontare il vento, ma anche lasciarsi andare all’onda”. Sì, era una città di contrasti, sincretica, come Istanbul; e come Istanbul una città ponte, anche al suo interno e nella vita quotidiana, tra diversi luoghi e culture. Proprio come lei cercava e amava: aveva visto giusto, era Trieste che avrebbe sempre più riempito il vuoto di quel suo hüzün.
Certo la città contemporanea, a quel suo primo contatto diretto, sembrava ben diversa da quella raccontata dai libri di storia e dalla tradizione letteraria. Appariva rinata, sembrava aver risolto in una nuova, perseguita e faticata complessità, in cui un grande ruolo era stato acquisito dalla scienza, sia il rivendicazionismo per quell’annessione all’Italia che si era rivelata inferiore alle aspettative, sia il ripiegamento nostalgico verso il passato. Non c’era più nessuna grandezza da rimpiangere, la città era grande nuovamente e diversamente, e nell’animazione lieta dell’oggi si percepiva sia l’effervescenza antica di un tempo, sia quella peculiare del presente, che rendeva la stragrande maggioranza degli abitanti disinvoltamente orgogliosi di quel loro Heimat. Persino la complicata convivenza tra italiani e sloveni sembrava aver trovato una più rilassata e serena modalità, e non solo fra gli intellettuali. Trieste era forse italiana, ma differente da ogni altro luogo della pur composita nazione. Forse la sua cifra era proprio la mancanza di ogni precisa identità, nonostante il tratto forte e unificante del dialetto triestino, che tutti parlavano alternandolo agilmente ad altre e diverse lingue.
Nel suo primo viaggio – considerava infatti viaggio zero la sua toccata e fuga giovanile – il contatto di Maura con Trieste era cominciato dalle Rive, per l’attrazione che sempre, su di lei, esercitava il mare. Le aveva percorse già in serata, all’arrivo, dirigendosi a piedi verso il B&B che aveva scelto nei pressi di piazza Unità d’Italia. Camminando si era fermata ammirata sul ponte in direzione del Canale e di Sant’Antonio, ma la piazza l’aveva raggiunta solo dopo aver depositato il bagaglio e cenato in un piccolo locale, e dunque già immersa nel buio e illuminata. L’aveva approcciata di lato e a colpirla, ancor prima degli sfolgoranti palazzi del potere che la incorniciavano e della luna sull’orologio della torre comunale, erano state l’ampiezza dello spazio e le luci blu della pavimentazione: le piacevano, quasi un sentiero che preludeva al mare, per poi innalzarsi in un plotone di sentinelle – piccoli palombari dagli occhi blu – nella sua prossimità. Guidata da quell’azzurra parata e dallo sciabordio leggero, quasi impercettibile della risacca, si era avviata verso il molo, l’audace molo, misteriosamente in ombra con i suoi radi lampioni. È giusto che sia così, pensò, quella scia di masegni che si addentrava nella scura superficie marina – l’ardita sottile lunghezza le ricordava l’episodio biblico della separazione delle acque del mar Rosso nel libro dell’Esodo – non avrebbe tollerato troppa illuminazione artificiale: era fatta per ascoltare quanto, dall’intimo, affiorava di latente e segreto.
Aveva raggiunto, quasi in stato di ipnosi, l’estremità del molo, e quando si era girata per tornare sui suoi passi aveva finalmente visto la luminosa magnificenza della piazza e delle Rive, amplificata e moltiplicata dal rispecchiamento nell’acqua delle luci e dei palazzi. Ne era rimasta abbacinata e conquistata, pur se sentiva di appartenere maggiormente alle arcane lontananze marine che si stava lasciando alle spalle. Era curiosa di vedere l’effetto di tutto quello scintillio nella luce del giorno successivo, che sarebbe stato terso e azzurro. Ormai l’azzurro accecante lo poteva sopportare, anzi era tornato a entusiasmarla.
Si era dunque recata di nuovo in piazza Unità di primo mattino e, nel chiarore naturale, aveva potuto considerare con più agio e naturalezza l’insieme di quella che era stata la piazza Grande, prima di cambiare nome in ragione del fatto che il 3 novembre 1918 il cacciatorpediniere Audace, prima nave italiana, aveva attraccato sul molo San Carlo che, al pari della piazza, aveva mutato la denominazione. Trieste era stata abbandonata dal governatore austroungarico già da alcuni giorni, così in mezzo a una folla entusiasta il generale Petitti di Roreto era sceso dalla nave e, in nome di Vittorio Emanuele III, aveva preso possesso della città. Piazza Unità d’Italia dunque – pur se i triestini la chiamavano familiarmente piazza Unità – e mai cambio di nome era stato così carico di storia e di significato: il destino italico di Trieste sembrava compiuto, pur se tante dolorose vicende e contese l’avrebbero ancora attraversata.
La piazza, rigorosamente geometrica e un tempo occupata da un giardino, era stata concepita nel 1869 dall’architetto Giuseppe Bruni, come espressione di quel positivismo ottocentesco che ben incarnava la fiducia nella logica e nella disciplina della mentalità asburgica. Le architetture dei palazzi che la circondavano non erano particolarmente apprezzabili, ma incarnavano bene la rappresentatività del potere e l’importanza che aveva assunto quel ricco e animato porto dell’impero austroungarico: il grande Palazzo Municipale, quello del Lloyd triestino, quello del Governo e, a non dimenticare anche gli svaghi, le relazioni, i fermenti culturali e le discussioni che una città così vitale intratteneva, il Caffè degli Specchi che fin dal 1839 vi aveva trovato collocazione. Il tratto architettonico più innovativo e coraggioso di quell’enorme spazio era stato l’averlo aperto direttamente sul mare, e a questo doveva ancora oggi la sua ampia peculiare spettacolarità. Esaltata, in contrappunto se non addirittura in metaforica contraddizione, da quel molo Audace lungo e spoglio che Maura avrebbe presto scelto, tra le molte suggestioni di Trieste, come il luogo giusto per sé.
Il molo, che era stato edificato a metà Settecento utilizzando come base il relitto della naufragata nave San Carlo, era stato un attracco di navi passeggeri e mercantili, con un gran pullulare di persone e di merci. Ora vi approdavano imbarcazioni solo saltuariamente – le navi crociera per spettacolo e propaganda, gli yacht e le vele della grande regata Barcolana – ma più che altro era diventato un affascinante nastro di passeggio proteso sul mare per famiglie, innamorati, menti pensose e cuori solitari. Senza soffermarsi troppo sulla piazza, Maura aveva raggiunto il molo e vi si era inoltrata. Il giorno era limpido e ventilato – vento di borino, avrebbe appreso nel tempo – il cielo e il mare di lapislazzuli e, del mare, sentiva nelle narici l’esalazione iodata e il profumo. Aveva l’impressione di trovarsi sul ponte di una nave: “Potrà il marinaio capire, / come noi cresciuti tra i monti, / l’ubriachezza divina della prima lega / lontano dalla terraferma?”. Quei versi dickinsoniani ancora una volta la attraversavano: e no, il marinaio non avrebbe potuto capire l’ebbrezza che, dalla sua città di tufo arroccata su un colle, su quel molo provava lei.
Dalla rosa dei venti dell’estremità la vista era magnifica e disegnava un superbo emisfero: dal golfo alle Rive, a piazza Unità, al retro del Teatro Verdi, alla chiesa ortodossa di San Nicolò, al colle di San Giusto, al monte Grisa, alle propaggini del Carso e, giacché il giorno era terso, fino alle Alpi Giulie che in lontananza emergevano dal mare. Nella sua retta semplicità, il molo era potentemente scenografico; e se la piazza rappresentava la prudente solidità degli Asburgo, la loro propensione a edificare, il molo era esattamente il contrario: l’abbandono all’onda, all’ignoto, al rischio. Anche se nei giorni successivi si era concentrata sui percorsi culturali, sui musei e su altri aspetti della città, un’immersione in quella morsa fascinante del molo Audace l’avrebbe fatta quotidianamente. “Per me al mondo non v’ha un più caro e fido luogo di questo”, aveva scritto Saba. Per Maura era sì un luogo caro, ma più che “fido” era avventurosamente rischioso, un trampolino da cui lanciarsi in territori inesplorati accogliendo l’invito dei tramonti della sera.
A San Giusto era salita tre volte abbordandolo da itinerari diversi: dal Teatro Romano, dall’Arco di Riccardo, dalla Scala dei Giganti. Rimuginava versi di Saba vagando in Cittavecchia, alla ricerca di quel cantuccio a lui solo e della celebre scontrosa grazia della città.
Aveva visitato i musei principali – il Sartorio, il Revoltella, nei bei palazzi di quella borghesia ricca e illuminata che aveva lasciato le proprie dimore, i patrimoni d’arte e i propri beni alla città – e, ineludibile per la sua generazione sessantottina e libertaria, il Parco di San Giovanni che, grazie alla rivoluzione psichiatrica di Franco Basaglia e di Beppe Dell’Acqua, aveva aperto i cancelli alla fine degli anni Settanta e aveva fatto di quell’ospedale psichiatrico un’insostituibile esperienza pilota nell’ambito della salute mentale. Negli anni, grazie al concetto e alla pratica dell’assistenza diffusa, il parco aveva perso la triste connotazione di un tempo quasi completamente, se non per ricordare, con la statua di Marco Cavallo, quel positivo sovvertimento. Ora la città vi era penetrata e ne aveva fatto un luogo di vita sociale e di cultura ancor più piacevole di altri: ospitava uffici, dipartimenti universitari, cooperative sociali, un teatro, un caffè-ristorante, la sede di una radio e, meraviglia delle meraviglie, un magnifico roseto: con le esuberanti rose di settembre in quel momento che, come un amico rodologo le aveva da tempo spiegato, sono meno copiose ma più belle e di lunga durata di quelle di giugno.
Si era goduta la bella atmosfera del quartiere di Cavana, che percepiva come un affascinante miscuglio di discreta moderazione asburgica e di disinvolto agio francese. Come tanti, alla Libreria Antiquaria Umberto Saba di via San Nicolò – il “nero antro sofferto” del poeta – era rimasta lungamente e amabilmente prigioniera del molto gentile ma logorroico figlio del “buon Carletto”, il fedele commesso e poi socio di Saba.
A Miramare non era andata, la ricordava piuttosto bene da quel lontano viaggio giovanile, ci sarebbe tornata una prossima volta… Perché sarebbe ritornata, sarebbe ritornata e, come nell’amore, bisogna sempre lasciare qualcosa di inesplorato per tornare con desiderio al luogo che comincia a occuparci il cuore. Piuttosto aveva preferito raggiungere Massimiliano d’Asburgo a Piazza Venezia, sostando a lungo di fronte a quell’ombreggiato monumento – sproporzionatamente maestoso nel piccolo slargo alberato su cui insisteva – che ricordava lo sventurato fugace imperatore del Messico e, a lei, l’inevitabile struggente rovina di ogni vanitas. Non aveva avuto neanche il tempo di godere di quel suo candido castello, Massimiliano, di sostarvi più a lungo con l’amata Carlotta, pur se si poteva comprendere che, dagli azzurri e aperti orizzonti di Miramare, non si fosse sottratto a salpare per la lontana avventura messicana.
Era stata, naturalmente, anche alla Risiera di San Sabba, l’unico luogo in Italia di detenzione ed eliminazione di detenuti politici e di ebrei dopo l’8 settembre 1943. Una visita dolorosa e religiosa, che l’aveva riportata alla luttuosa storia degli anni del fascismo, che a Trieste, attraversata dalle rivendicazioni slovene e dalle mire della Jugoslavia, era stato particolarmente duro e violento. Così che le tragiche esecuzioni della Risiera avevano rappresentato ben più di una manifestazione di odio razziale, aggiungendovi l’arma funesta del sospetto e delle vendette di matrice politica. Le sembrava crudele, quasi beffardo, che la città diventata grande in virtù dell’apertura e della tolleranza del porto franco, che aveva accolto ogni tipo di etnia, di ceto sociale, di cultura e di religione, avesse abdicato a tal punto a quella sua lontana e felice storia. Per non parlare delle vicende successive all’insurrezione anti nazista del 25 aprile 1945, che per Trieste non aveva significato una liberazione, ma un’occupazione da parte delle truppe jugoslave di Tito, che avevano perpetrato ulteriori e brutali episodi di odio, vendetta e terrore. Diventata Territorio Libero di Trieste ed entrata, a causa della guerra fredda, in una situazione politicamente stagnante sotto il controllo delle truppe alleate, la zona triestina era tornata all’Italia solo nel 1954, e la questione delle terre istriane e dalmate, contese da Italia e Jugoslavia, si era trascinata fino al trattato di Osimo del 1975. La storia di Trieste era molto complessa e intricata, di ardua decifrabilità, ma questo per Maura non rappresentava che un’attrattiva ulteriore: avrebbe cercato di approfondirla.
Era rientrata a casa, dopo quel primo soggiorno, con la sensazione di quando ci si immette in qualunque tipo di serio studio: più si indaga, più si scopre e meno sembra di sapere, più si sente forte il bisogno di colmare le deficienze e i vuoti.
A Trieste era tornata l’estate successiva, per una residenza di poesia e letteratura. E quella circostanza le avrebbe aperto, grazie a una serie di esperienze e di relazioni, la vera reale frontiera della città. Nel senso che dalle conoscenze di viaggio sarebbe passata a quelle quotidiane e dirette e, grazie ai ripetuti soggiorni, alla frequentazione di luoghi e di eventi, alle amicizie, a qualche collaborazione di lavoro – e a quei frizzanti piaceri che tra osmize, locali tipici e caffè, i triestini e le triestine non si fanno mai mancare – si era man mano sentita non più ospite ma parte della città. Tutti, tutte pensavano, si interrogavano, scrivevano, leggevano, si impegnavano in qualcosa a Trieste, ma senza dimenticare il gusto più semplice e disinvolto dell’esistere: era proprio lo stile di vita che lei amava.
Aveva piacevolmente sorpreso il grande scrittore della città letteraria contemporanea ordinando, al Caffè del primo incontro, un gocciato. Ho studiato prima di venire a Trieste! aveva detto, con spontanea e divertita ironia, di fronte al suo stupore. E chissà, forse anche quel gocciato, dovuto alle brillanti nozioni in merito impartite dalla Trieste sottosopra di Mauro Covacich, aveva stabilito la sintonia di successive elettive affinità. Era riuscita persino a far ridere il sempre pensieroso quasi mesto Covacich, quando aveva avuto occasione di incontrarlo a un festival letterario, e gli aveva raccontato quell’aneddoto con gratitudine per quel suo prezioso libricino. E di Trieste avrebbe via via conosciuto e scoperto anche autori e pensatori del passato meno noti a chi triestino o triestina non è, e i tanti tantissimi contemporanei: una folla di poeti, poete, scrittori, scrittrici, studiose, studiosi. E anche, avrebbe scoperto, le notevoli scrittrici del primo Novecento, tanto per cambiare dimenticate dal canone ufficiale e riportate all’attenzione dall’editoria femminile: Ida Finzi, Pia Rimini, Willy Dias, Anna Curiel Fano, Alma Morpurgo. E Anita Pittoni, l’unica donna a cui era dedicata un’erma nel Giardino Pubblico, non solo scrittrice, ma abile artigiana del tessile e della moda e, soprattutto, fulcro di un importante salotto letterario e ideatrice di quelle raffinate edizioni dello Zibaldone che avrebbero pubblicato importanti classici della cultura triestina, ma anche opere di stranieri, viaggiatori e pittori residenti nella città. E ancora avrebbe incontrato, letto, ascoltato e apprezzato il grande poeta contemporaneo di Trieste, Claudio Grisancich, che aveva esordito giovanissimo proprio grazie ad Anita, e alla cui opera Maura doveva la prima acquisizione di un dialetto triestino almeno basico, che non avrebbe mai osato parlare, ma che le permetteva di comprendere i normali abitanti e i letterati che, nella stessa conversazione, passavano continuamente dal dialetto alla lingua.
La città la entusiasmava, pur se non voleva farne un quadretto agiografico e ne vedeva anche i problemi, le più o meno piccole miserie e rivalità, gli inevitabili veleni. “Una città / di chiacchiere / discorsi a vuoto / parole riportate / meglio se acri / sottili trame / impantanate / e brani sparsi / a volontà”, aveva descritto con versi icastici Gabriella Musetti. Ma Maura era di fuori, veniva a intermittenza e, prendendo il meglio, sul resto poteva sorvolare.
Volando e sorvolando, nel tempo era stata in grado non solo di mettere insieme molte informazioni, ma di estrarne le sue impressioni, di scegliere, di decifrare quello che più la legava a quella città così complessa e stratificata, in cui poteva ben dire, come Joyce, che si era depositata la sua anima. Sentiva che quel “nessun luogo” le apparteneva: per il semplice fatto che, non sentendosi cittadina di alcun luogo, era solo di un “nessun luogo” che poteva essere parte. Com’era complicato rappresentare questa solida solo apparente evanescenza, eppure ne sentiva la consistenza così bene. Quella diaspora di popolo sui generis descritta da Jan Morris, per cui Trieste secondo la scrittrice si sarebbe potuta configurare come la capitale, era l’unica a cui Maura avrebbe potuto appartenere. “Sono di tutte le razze – scriveva Morris. – Possono essere giovani o anziani, uomini o donne, soldati o pacifisti, ricchi o poveri. Quando ti trovi tra loro sai che non susciterai scherno o irritazione, perché non si cureranno della tua razza, o fede, o sesso o nazionalità. Ridono di buon grado. Sono pronti alla gratitudine. Non si lasciano inibire dalla moda, dall’opinione pubblica o dalla correttezza politica. Sono esuli nelle loro stesse comunità perché sono sempre in minoranza”. Ma oltre a questo, per lei quel nessun luogo era molto di più, era il non spazio in cui qualche bizzarro imprevisto poteva accadere.
E ora, quella mattina, era il 25 giugno 2021 e ancora una volta si trovava sul molo Audace. Erano quasi cinque anni che frequentava la città: dall’azzurro polvere di Istanbul era definitivamente passata all’azzurro intenso di Trieste. Neanche le sue bore, purché chiare, la intimorivano più ma, proprio come ai triestini, le pulivano la mente e il cuore da scorie tristi e letali. Con gli occhi di oggi, in fondo era stato un bene perdere quell’antico grande amore, che si univa a un lavoro non del tutto necessario e che, con la velocità e la gabbia temporale e convulsa del giornalismo, le tagliava le ali per le sue vere ambizioni letterarie. Forse non erano neanche più due i luoghi che più amava: lentamente, pur se le restava in cuore, Eminönü era stato offuscato dal molo Audace.
Trieste, l’Italia, l’Europa, il mondo stavano appena uscendo dall’incubo del Covid-19, la pandemia del nuovo corona virus che aveva duramente provato il pianeta. Le persone, e anche le città, dopo quel deserto di mesi non erano più le stesse, provavano a rinascere con qualche difficoltà. Magari Trieste, con quel suo popolo di mare e di Carso, si sarebbe ripresa prima di altre, pensava nell’aria frizzante di borino, rimirando il mare di vivo cobalto dall’estrema punta del molo. E lei, donna matura, sentiva di fronte all’onda e a tanta vitale marina bellezza che le sarebbe persino potuto capitare di innamorarsi ancora. Anzi, desiderava innamorarsi, dopo tutti quei mesi asettici di solitudine e di paura dell’altro e del corpo. Oh, certo, le amiche avrebbero avuto da ridire – non le bastava tutta la sofferenza che per amore aveva attraversato? alla sua età aveva ancora il coraggio di innamorarsi? – ma lei sì, sentiva che avrebbe potuto avere ancora quel coraggio: perché amava rischiare come chi un tempo partiva da quel molo; e perché, proprio come quel molo, era audace.
Le vennero in mente dei versi tra il ribelle e lo scanzonato, prese il quaderno che portava sempre con sé e, seduta sull’ultima panchina del molo, li appuntò. A volte, si disse, le cose accadono perché le abbiamo immaginate e scritte. Tracciò gli stessi versi due volte, su due fogli differenti. Un foglio lo strappò, lo ripiegò e lo buttò in mare. Quel suo indecente desiderio cominciò a beccheggiare, a volteggiare a pelo d’acqua:
Se proprio dovessi amare ancora
da vecchia – dell’amore che si fa carne acqua
sangue e pulsione intendo – vorrei amare
da pazza un vecchio pazzo – o un giovane
purché pazzo
qualcuno che mi chiamasse nella notte senza le discrete
accortezze di Messenger o di WhatsApp
con la musica forte del telefono – con la voce
disturbando solo per dire che mi sta pensando
o che una mia parola o un gesto complice ricorda
o quel colore, quel blu pervinca del giacchetto
che mi sta così bene con la nuvola grigia
scomposta poco domestica poco rinunciataria
dei capelli – con lo sfumare chiaro quello sì discreto
dell’ombretto – con gli orecchini belli di giaietto
qualcuno che non avesse timore di prendere un aereo
una nave un treno – di viaggiare due giorni per incontrarmi
due ore – di darmi appuntamento col mare in tempesta
su un molo perché da troppo senza me si sente solo
qualcuno che accettasse le mie proposte audaci sconsiderate
per dirmi quanto sei matta – ma così matta mi piaci
un pazzo – non importa se giovane o se vecchio –
che mi donasse un lembo scuro vellutato di viola
per portarlo con me quando – davvero –
nella terra sarò sola
Mentre le sue parole viaggiavano chissà per dove guardò l’ora, era quasi mezzogiorno. La luce di quel mattino di fine giugno era davvero accecante, strinse le pupille. Niente è più frequente in estate dell’amore, quando non vediamo quasi nulla è più probabile che c’innamoriamo.


