di Laura Ricci
dal N. 61, Ottobre 2020, della rivista Il Ponte rosso
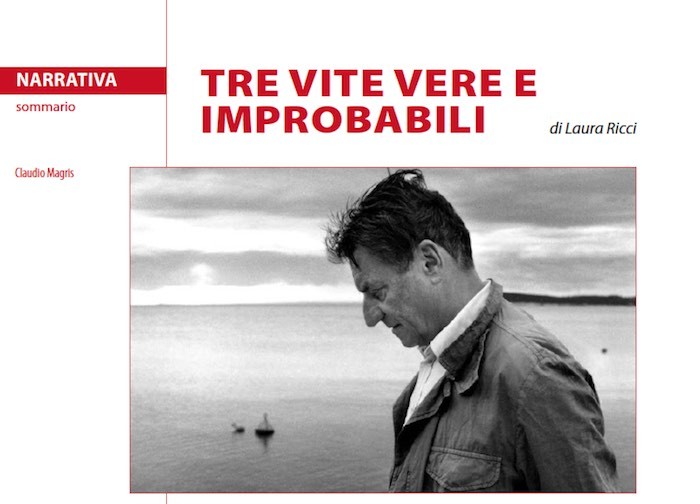
Il grande Sud e la strabiliante originalità della vita sono da tempo motivi ricorrenti nel pensiero e nelle opere di Claudio Magris, che nel suo ultimo lavoro – Croce del Sud – fonde questi topoi a lui cari in una potente epopea per narrare, come il sottotitolo avverte, “tre vite vere e improbabili”. Si tratta di tre esistenze estreme trascorse tra Araucania e Patagonia, in quelle vaste terre ai limiti del mondo abitato che videro flussi di avventurose migrazioni, contese e guerre poco note al Nord del mondo, spaventose stragi da parte dei colonizzatori bianchi che portarono alla decimazione, talora all’estinzione delle popolazioni autoctone. Fedele, come altri suoi amati scrittori, all’assunto che la realtà è più fantasiosa e imprevedibile della finzione, Magris restituisce tre destini diversamente eccentrici, radicali e generosi, accomunati da una vita oltre i limiti del credibile, dagli scenari di inquietante bellezza in cui la loro storia si svolge e dall’aver sfidato, ognuno secondo la propria personalità, la barbara devastazione di quei luoghi e la crudele persecuzione degli indigeni.
“Ogni invenzione, grande o modesta, si nutre di cose realmente accadute e di persone realmente esistite che la vita […] le fa capitare inopinatamente fra le mani”, scrive Magris nella nota finale di Non luogo a procedere. E questa volta, a capitare sotto la penna dello scrittore sono, nell’ordine del libro, Janez Benigar (1883-1950), quasi ingegnere, antropologo, linguista, pensatore, che elegge a patria il luogo di immigrazione; Orélie-Antoine de Tounens (1825-1878), avvocato e avventuriero francese che si autoproclama re di Araucania e Patagonia, dunque di un regno che non c’è, lottando strenuamente, pur se assurdamente, per la libertà dei Mapuche; e Suor Angela Vallese (1854-1914), umile e coraggiosa salesiana del Monferrato, missionaria nella Terra del Fuoco, che dedica la sua esistenza agli autoctoni sfruttati e massacrati. E giacché la penna che scrive è originale e magistrale, dirò subito che non si tratta di tre narrazioni convenzionali, ma di tre storie monologanti e per molti versi oniriche che oscillano continuamente tra biografia, racconto e saggio, sfuggendo a ogni codifica di genere e disegnando, tra notazioni e digressioni, non solo le vite reali – e improbabili – scelte, ma anche ampi squarci della biografia letteraria di chi le scrive.
Janez Benigar – austro-slavo di Zagabria, giunto a Buenos Aires il primo ottobre 1908 con la nave Oceania partita da Trieste e ben presto spostatosi, per insofferenza delle città, verso Araucania e Patagonia – non può non rammentare, per provenienza dall’impero asburgico in declino, destinazione e narrazione magrisiana, Enrico Mreule, il protagonista altrettanto vero e poco meno improbabile di Un altro mare (1998), anch’egli gaucho in Patagonia dal 1909 al 1922, quando tornò a Gorizia per scomparire di nuovo, dopo un decennio, nei pressi di Salvore. Ma Enrico è una dramatis persona quanto mai inquieta, il cui amore per la vita approda all’impossibilità di vivere, un fuggiasco dell’anima anche nell’immobilità sul suo scoglio, mentre Benigar, ricordato come «El cacique blanco» e «El sabio que murió sentado», è secondo le testimonianze della storia e le parole di Magris “un uomo posato e abitudinario, incline a una pedanteria tutta austriaca”, che con questa pignoleria “parte per l’Argentina ovvero per la Patagonia e l’Auracanía, da dove non tornerà mai più e dove per diciannove anni non metterà piede in una città, salirà una sola volta su un’automobile, non vedrà mai un aeroplano e vivrà molto tempo nei wigram, le tende del popolo indio divenuto anche il suo, tende che più tardi gli suggeriranno pure una modesta ma avviata attività di artigianato tessile, una piccola industria famigliare”.
Equilibrato, indole da studioso, organizzato e industrioso, padre di numerosi figli avuti da due mogli araucane molto amate – la nobile mapuche Sheypukíñ ovvero Eufemia Barraza e, dopo la morte di lei, Rosario Peña – Benigar è un pater familiae che si prende cura non solo della vita quotidiana dei propri familiari, ma anche delle condizioni di vita e degli interessi degli Indi che abitano le terre che ha scelto lasciando l’Europa. Gringo sloveno, criollo araucano – così Magris intitola il racconto a lui dedicato – pur spostandosi in varie località e impiantando coltivazioni e attività per le piccole pacifiche comuni che gli gravitano intorno, non è un gaucho armato e errabondo, ma uno stanziale che attraversa quelle terre spietate e violente senza pistola, senza coltello e senza frusta, un epigono rousseauiano che al sangue, ai totalitarismi e allo sterminio oppone la puntualità del pensiero e dell’azione. Sempre più prossimo alla zona di Aluminé, dove trascorre gli ultimi venticinque anni di vita e dove oggi una biblioteca e un centro culturale portano il suo nome. Denuncerà beninteso i soprusi del colonialismo e del capitalismo che cancellano identità e culture, le ingiustizie e le violenze subite dagli Indios, ma in nome della democrazia, della piccola proprietà e dell’ordine piuttosto che delle rivoluzioni, e lo farà con la penna, con chiarezza e coraggio, “sempre attento a problemi concreti, illeciti pubblici e imbrogli nei confronti degli Indios, espropriazioni, alterazioni delle loro condizioni di vita e dell’ambiente necessario alla loro vita”. Con la stessa metodica diligenza con cui si adopera per migliorare il rancho che possiede o le condizioni di vita di alcuni villaggi araucani, scrive opere di antropologia e etnologia per illuminare una civiltà e una lingua che, in un’armonica identità multipla, ha fatto sue. Il linguista-filologo sia pure dilettante che in gioventù aveva messo a punto in breve tempo una grammatica bulgara, dedica innumerevoli anni a studiare la lingua araucana e, verso la fine della vita, scrive La Patagonia piensa, un ampio saggio di impegno civile in cui, proclamandosi “figlio spirituale della Patagonia”, polemizza verso progetti governativi che ancora un volta mirano a snaturalizzare e ostacolare lo sviluppo di queste terre. In sintesi, è un «giusto» eclettico, equilibrato e utopico, che può far sorridere per sorpassata ingenuità, ma con cui lo scrittore solidarizza sperando in qualche improvvisa deviazione della Storia verso il bene.
Di tutt’altro stampo la seconda esistenza che si consuma, più breve e folle, sotto il cielo della Croce del Sud: quella di Orélie-Antoine de Tounens che, pur essendo figura reale, sembra piuttosto appartenere all’invenzione crudele e visionaria di quel sublime capolavoro magrisiano che è il romanzo Alla cieca. Orélie Antoine, che in omaggio all’Araucania di cui volle essere fantomatico monarca cambiò il nome in Aurelio-Antoine I, ricorda per certi aspetti Jorgen Jorgensen, il re d’Islanda che si ritrova agli antipodi condannato nell’inferno del penitenziario di Porth Arthur, nell’isola di Tasmania, anche lì nel Sud profondo spalancato verso i ghiacci dell’Antartide, pur se a qualche meridiano di distanza. Solo che questa volta non siamo di fronte a un protagonista uno e plurimo che, sia pure con agganci storici, si muove nel mondo paradossale dell’invenzione, ma a una vita realmente vissuta di cui Magris ricostruisce la storia fino agli epigoni contemporanei: l’ultimo successore di una stirpe che mai ha regnato è, dal 2018, tale Frédéric Luz, studioso di araldica.
Come giustamente il suo scrittore osserva, l’avvocato massone di Périgueux è una figura di avventuriero pienamente ottocentesca che, tra melodramma e vaudeville, è incline al pathos e ai grandi gesti. Vagheggiando fin dai tempi della sua tesi di baccellierato – La conquista e la proprietà dinanzi al diritto delle genti – la liberazione dell’Araucania e una corona per sé e la sua famiglia, che reputava discendente dagli imperatori di Bisanzio e dai signori d’Aquitania, nel luglio del 1859 raggiunge quegli incerti territori contesi tra Cile e Argentina, fiaccati e razziati dai Conquistadores di cui mai i fieri Mapuche, rintanati e sparsi nelle foreste, riconosceranno l’autorità e tanto meno l’appellativo di Araucani che viene loro imposto. A influenzare il suo immaginario è il poema cavalleresco La Araucana di Alonso de Ercilla (1590), che Voltaire aveva considerato un capolavoro della letteratura universale e che aveva fatto di Lautaro, l’eroe e generale araucano più volte vincitore dei Conquistadores, un valoroso personaggio della letteratura spagnola; ma di certo anche un sincero e nobile senso di giustizia, che gli fa vagheggiare il suo regno come la fine delle violenze e delle ruberie che distruggono gli Indios, la loro cultura e le loro condizioni di vita. La annuncerà al mondo il 17 novembre 1860 la nascita del Regno di Araucania, dopo uno sbarco a Valparaiso, lo studio dello spagnolo e del mapudungun, un viaggio con due compagni inventati di cui uno già nominato ministro e un memorabile incontro, in una radura delle Ande, con il cacique Quilapán e i suoi cento cavalieri. Con grande piglio teatrale, ma purtroppo anche caricaturale, in breve tempo Aurelio-Antoine I redige una costituzione, nomina ministri, un Consiglio del Regno, un Consiglio di Stato e un Corpo legislativo, sfodera un tricolore azzurro-bianco-verde, istituisce ordini cavallereschi e medaglie di merito, apre ambasciate nel mondo e, ottenuta l’adesione dei patagonici Tehuelches, trasforma il regno in una Federazione di Araucania e Patagonia che si estende, a suo dire, dal 42° di latitudine a Capo Horn.
La parabola della vita di Orélie-Antoine de Tounens, tra derisioni internazionali e azioni governative volte a contenere le sue surreali farneticazioni, precipita tragicamente ma fieramente resiste. Uscito dalle carceri e dai manicomi cileni Orélie torna in Europa, dove vive di espedienti e cerca fondi e aiuti per la causa araucana: irriso dai giornali, espulso dalla massoneria, ma al tempo stesso miserevolmente aiutato da enti e persone che si impietosiscono per la sua patetica follia. Tornerà in Araucania due volte, con tentativi grotteschi e rocamboleschi di riprendere un potere mai avuto.
Ammalato di cancro e tornato definitivamente in Francia, si stabilisce in casa di un cugino a Tourtoirac e sopravvive grazie agli aiuti della Camera degli Avvocati di Francia e ad altre modeste sovvenzioni. All’ufficio dello stato civile di Tourtoirac il suo decesso è registrato come “morte di Antonio de Tounens, ex re di Araucania e Patagonia”, e il villaggio conserva a tutt’oggi la sua bizzarra memoria celebrando, ogni anno in agosto, una festa. Vari studi psichiatrici, in vita e in morte, hanno definito il suo progetto “idea demenziale perseguita con un comportamento ostinatamente logico”, ed è proprio quel “cocktail di demenza e logica – osserva Magris – la corazza che gli permette, grazie alla sua mania più forte del destino, di restare impermeabile alle catastrofi, sconfitte, umiliazioni”. La sua follia, secondo lo scrittore, pur se ridicola merita l’onore delle armi, perché “la sua sfida trafigge, come in un duello, l’ottusa e crudele corazza della cosiddetta realtà e incide su quest’ultima. Anche grazie ad Aurelio-Antoine I il dramma dei Mapuche è entrato, almeno in minima parte, nella consapevolezza del mondo. Quella follia è più umana – e dunque più razionale – della violenza e della comunella dei malvagi, come la chiama Michelstaedter”.
Con l’ultimo racconto del libro, Suore e pinguini dedicato a Suor Angela Vallese, torniamo al mondo sensato e organizzato di una straordinaria quotidianità. È certo un’esistenza eccezionale quella della piccola suora di Lu Monferrato il cui abito bianco e nero la fa prendere, dagli indigeni della Terra del Fuoco, per un pinguino, ma tutta scandita da una serena regolata concretezza e dal preciso tracciato di una missione di sorellanza e di amore universale da compiere. Pioniera dell’opera missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Suor Angela giunge in Patagonia nel gennaio 1880 e assiste, in quel mondo di estrema bellezza e di spietata violenza, alla progressiva estinzione degli Indios fuegini. Con grande dolore, ma con altrettanto amore, senza permettere che la sua empatia per il loro tragico destino offuschi la chiarità della sua persona e la gioia di poterli aiutare: rispettando la loro cultura, ma insegnando loro quanto può sollevarli nella dura esistenza e “continuando a far lavorare le mani, il cervello e il cuore per loro e per tutti gli altri della «benedetta Terra del Fuoco», come amava ripetere”. Perché quella terra, che attraversa indomitamente con il suo fragile ma addestrato fisico di donna, è pur sempre una manifestazione del divino e, con lietezza francescana, Angela impara ad amarne le manifestazioni di vita naturale e umana. L’interezza è la sua virtù: azione minuta e lucido pensiero, capacità di intessere e coltivare relazioni, sorriso e illuminata caparbietà, umiltà e autorevolezza. In stretto rapporto con il salesiano Monsignor Fagnano, l’ardito e disinvolto missionario gaucho che è il punto di riferimento delle suore, Angela e le Sorelle riescono ad avvicinarsi con più agio alle tribù fuegine, che le considerano «Madri buone», e ad alleviarne le numerose difficoltà.
Con empatica ammirazione, Magris percorre con ritmo veloce e poetico l’agire di Angela: quasi un salmo di una moderna Bibbia d’amore la sua narrazione, che condensa in poche immagini una vita che, pur non dimenticando la dimensione contemplativa della preghiera, si esplica soprattutto in un generoso attivismo. “Oh benedetta Terra del Fuoco”: viaggi continui tra Punta Arenas e l’ancor più aspra e inospitale isola di Dawson, e altre isole e luoghi abitati da Ona, Tehuelches, Alakafules, Yamana; senza nessun mito del buon selvaggio, che è sempre meglio avere di fronte piuttosto che di spalle, senza nessuna ingenuità di fronte al sangue e al male, ma mai rinunciando a qualunque apporto di positività; piccoli gesti quotidiani, insegnamenti d’igiene, ma anche laboratori di cucito e di calzoleria, scuole, ospedali. “Oh benedetta Terra del Fuoco”: a cavallo, in barca, nelle notti all’addiaccio, nelle bufere, di terra in terra e di tribù in tribù, senza mai scandalizzarsi degli usi degli indigeni che, lei dice, “vanno considerati alla pari con i bianchi civilizzatori, non resi uguali ad essi”. Giustamente lo scrittore suggerisce per lei la vicinanza con figure come Teresa de Avila e Simone Weil. Come Teresa, in effetti, dal mio punto di vista Angela compie ogni giorno il poco che dipende da sé e conta, per non fallire, sulla relazione con il Superiore e le Sorelle; come Simone Weil assume e sperimenta il destino degli ultimi, non lasciando che la sua tragicità offuschi il suo amore per Dio e per l’umanità e la sua gratitudine del vivere. Vicinanza anche con l’azione di Etty Hillesum, aggiungerei, laddove nella sua scia potrebbe ben affermare: «Si può essere un balsamo per molte ferite, oh benedetta Terra del Fuoco».
La storia di Suor Angela Vallese così soffusa, negli accenti che la riguardano, di chiara limpida semplicità, è anche quella in cui si scatena più liberamente la fantasia associativa dello scrittore, e la sua inclinazione antropologica e letteraria per il grande Sud. In contrappunto con l’esperienza missionaria che racconta, sospesa tra l’eccesso di ogni temperamento mistico e una diligente minuta operosità, Magris ripercorre, in questo caso con scrittura potente e visionaria, anche la storia di fatiche e di orrori di quel mondo alla fine del mondo e quanto ne hanno scritto, surrealmente o scientificamente, innumerevoli scrittori. Associando o dissociando immagini, descrizioni e concetti delle loro opere, mette in vortice Salgari, Verne, Poe, Lovecraft, Coloane, Chatwin, e i resoconti spesso pregiudiziali e imperfetti di Darwin, e lo Yamana-English Dictionary del reverendo Thomas Bridges, che pubblicato nel 1933 raccoglie circa trentaduemila parole “che non saranno mai più pronunciate perché chi le usava non esiste più”. Fino allo scrittore italiano vivente Daniele Del Giudice, che “si avventura nei luoghi del laggiù – un laggiù in ogni senso, sempre più laggiù, c’è sempre un ulteriore abisso” nella sua opera Orizzonte mobile, che Magris definisce «il suo capolavoro estremo». Fino a una travolgente ricognizione antropofisica e geografica di questo estremo Sud del mondo dalla conturbante assoluta cristallizzata bellezza, con le sue proiezioni di luce che sembrano miraggi e invece sono vere, con i suoi uccelli “di bianco livore”, i suoi pinguini giganti, il buco inquietante dell’ozono, i toponimi legati a gesta ardite di esploratori, viaggiatori e navigatori, non ultimo quel Magellano che “scaraventò quelle terre nella Storia”.
Quanto può contenere, quanto può turbinare una mente? – ci chiediamo ancora una volta nel gorgogliante flusso della scrittura magrisiana, in questo colto personalissimo stream of consciousness che mescolando e frammentando elementi e registri diversi restituisce genialmente, oltre all’enorme ricettività che in effetti può esercitare la mente umana, vita e morte, stupore e orrore, ferocia e santità, l’assetto e lo sconquasso che da sempre contraddistinguono i cicli della Natura e della Storia. Nulla di nuovo, in fondo, sotto i cieli australi o boreali.
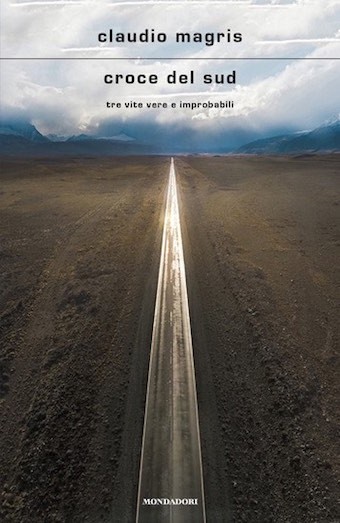 Claudio Magris
Claudio Magris
Croce del Sud
Tre vite vere e improbabili
Mondadori, settembre 2020
pp. 132, euro 15,00