Susanna Tamaro rievoca la sua amicizia con Pierluigi Cappello
di Laura Ricci, su Il Ponte rosso, n. 39/40 novembre/dicembre 2018
 Ogni libro da qualche tempo sembra essere l’ultimo per Susanna Tamaro. O almeno lei lo dichiara, uscendo ogni volta appagata, ma anche spossata, dal faticoso mestiere dello scrivere, che per lei, ipersensibile e multiantenne, è l’impresa sfibrante che chi scrive ben sperimenta e sa. Ma poi la vita continua, la mente, il cuore, le “grandi orecchie” di Susanna – secondo un’espressione che lei stessa ama usare per sé – continuano ad aprirsi alle forme, alle epifanie, all’esperienza del mondo e qualche nuovo libro, in questo farsi alveo e ascolto, inevitabilmente nasce. È accaduto così anche per il suo ultimo, Il tuo sguardo illumina il mondo, dedicato al poeta Pierluigi Cappello, che nella forma di una lunga lettera all’amico racconta il loro intenso rapporto, dipanandolo lungo il filo di varie e profonde riflessioni sulla vita e sull’esistere. “Considero La Tigre e l’Acrobata il mio testamento, ti ho confessato un giorno” – scrive in questo suo recente lavoro. – Dopo questo libro, vedo per me un futuro di grande silenzio”. E invece la morte di Pierluigi nell’ottobre 2017, la volontà di tenere fede a una promessa – quella di scrivere un libro insieme – e soprattutto, come in ogni romanzo, l’impulso a raccontare una storia, hanno spinto la scrittrice a riempire ancora una volta le pagine nello studio da cui, quasi nel suo farsi, il libro prende avvio: nel cuore dell’inverno, in una piccola spartana capanna nel bosco, riscaldata da una vecchia stufa Argo.
Ogni libro da qualche tempo sembra essere l’ultimo per Susanna Tamaro. O almeno lei lo dichiara, uscendo ogni volta appagata, ma anche spossata, dal faticoso mestiere dello scrivere, che per lei, ipersensibile e multiantenne, è l’impresa sfibrante che chi scrive ben sperimenta e sa. Ma poi la vita continua, la mente, il cuore, le “grandi orecchie” di Susanna – secondo un’espressione che lei stessa ama usare per sé – continuano ad aprirsi alle forme, alle epifanie, all’esperienza del mondo e qualche nuovo libro, in questo farsi alveo e ascolto, inevitabilmente nasce. È accaduto così anche per il suo ultimo, Il tuo sguardo illumina il mondo, dedicato al poeta Pierluigi Cappello, che nella forma di una lunga lettera all’amico racconta il loro intenso rapporto, dipanandolo lungo il filo di varie e profonde riflessioni sulla vita e sull’esistere. “Considero La Tigre e l’Acrobata il mio testamento, ti ho confessato un giorno” – scrive in questo suo recente lavoro. – Dopo questo libro, vedo per me un futuro di grande silenzio”. E invece la morte di Pierluigi nell’ottobre 2017, la volontà di tenere fede a una promessa – quella di scrivere un libro insieme – e soprattutto, come in ogni romanzo, l’impulso a raccontare una storia, hanno spinto la scrittrice a riempire ancora una volta le pagine nello studio da cui, quasi nel suo farsi, il libro prende avvio: nel cuore dell’inverno, in una piccola spartana capanna nel bosco, riscaldata da una vecchia stufa Argo.
La capanna e il bosco non sono molto lontane dal luogo in cui abitualmente vivo anch’io e, prima di spostarmi tra le armoniche e composte pietre cittadine di Orvieto, ho condiviso con Susanna Tamaro la stessa campagna umbra, gli stessi imponenti boschi di querce che attorniano il vicinissimo paese di Porano, dove ormai da trent’anni la scrittrice risiede: a contatto con la natura che si espande e muta, coltivando l’orto e allevando api. Coltivando solidarietà e relazione anche, perché, pur se riservata e schiva, sono molte le occasioni in cui, con la Fondazione che ha fondato, finanzia progetti educativi e di integrazione, e sono diverse le istituzioni, come le scuole primarie e l’Opera del Duomo di Orvieto, in cui porta le sue competenze, contribuendo alla vita culturale e sociale del territorio. Da qualche tempo condividiamo anche lo stesso treno, un modesto lento ma comodo Intercity senza cambio per una comune, inversa spola tra Orvieto e Trieste, la città in cui Susanna è nata e di cui io, come lei di questa mia terra, mi sono innamorata. “A Laura, con cui ho scambiato la città”, ha scritto con ridente ironia nella dedica apposta al suo ultimo libro, che ha presentato a Orvieto all’inizio di novembre, insieme al noto imprenditore e mecenate Brunello Cucinelli, sotto l’egida di parole impegnative come bellezza, sogni, etica, amicizia, eternità. Tutte parole che con questo suo ultimo lavoro hanno molto a che fare.
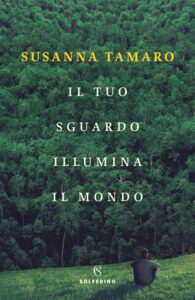 Il tuo sguardo illumina il mondo affronta temi molteplici: da una parte l’amicizia e le affinità elettive che hanno profondamente legato il poeta friulano e la scrittrice, dall’altra la ripresa di un’autobiografia ferma a qualche anno fa, prima dell’incontro con Cappello, quella che Tamaro aveva intessuto in Ogni angelo è tremendo. Era un raccontarsi doloroso, e anche Trieste e il Carso, scenario di una difficile infanzia e di un’adolescenza problematica, venivano tratteggiati nel libro come luoghi forieri di inquietudine e conflittualità. “Ora il rapporto è diverso – afferma – e non solo perché sono cambiati i luoghi, un tempo frontiera minacciosa, armata, difficile da attraversare, ora aperti e facilmente valicabili; ma perché sono cambiata io e, abituata ad altri paesaggi, ne ritrovo, con l’affetto della distanza, le peculiarità”.
Il tuo sguardo illumina il mondo affronta temi molteplici: da una parte l’amicizia e le affinità elettive che hanno profondamente legato il poeta friulano e la scrittrice, dall’altra la ripresa di un’autobiografia ferma a qualche anno fa, prima dell’incontro con Cappello, quella che Tamaro aveva intessuto in Ogni angelo è tremendo. Era un raccontarsi doloroso, e anche Trieste e il Carso, scenario di una difficile infanzia e di un’adolescenza problematica, venivano tratteggiati nel libro come luoghi forieri di inquietudine e conflittualità. “Ora il rapporto è diverso – afferma – e non solo perché sono cambiati i luoghi, un tempo frontiera minacciosa, armata, difficile da attraversare, ora aperti e facilmente valicabili; ma perché sono cambiata io e, abituata ad altri paesaggi, ne ritrovo, con l’affetto della distanza, le peculiarità”.
L’autobiografia che viene ripresa in questo nuovo libro non ha più il registro cocente della narrazione di allora, ma si dispiega in una conversazione duale, intima, che presuppone l’ascolto della propria interiorità e l’orecchio dell’amico, in un colloquio sommesso che l’Angelo della Morte può forse riuscire a ovattare, ma non a spezzare; stabilisce inoltre un discorso ponte con il racconto autobiografico che il poeta ha tracciato di sé in Questa libertà.
Con incantevole prosa Pierluigi Cappello si racconta, bambino e adolescente di belle speranze, fino al giorno del suo terribile incidente, quell’incidente in moto che il 10 settembre 1983, dopo il solito allenamento atletico – aveva sedici anni e era un promettente velocista – gli spezzò irreparabilmente, con tutte le conseguenze che ne derivarono, il midollo spinale. Il racconto si chiude il 16 marzo 1985, giorno in cui, dopo cure intensive, interventi operatori in vari ospedali, interminabili fisioterapie, viene dimesso dall’istituto di riabilitazione per raggiungere a Tricesimo la sua baracca di terremotato. E non solo perché da quel giorno è una persona nuova che dovrà affrontare una vita di difficoltà, ma perché, nel comprendere che sarà alla scrittura che affiderà il nocciolo e il ponte verso il mondo di quella nuova esistenza, consegnerà alla forma della parola poetica il suo successivo narrare. Tornerà a raccontarsi in prosa – ma pur sempre in una prosa intensamente poetica – nei suoi ultimi giorni, quando avverte che la Parca si sta avvicinando inesorabile (“Cassacco, anno zero”, in Un prato in pendio).
In un bellissimo passaggio chiave di Questa libertà, rammentato e ripreso anche da Susanna Tamaro, cercando di definire la vera poesia, Cappello parla dell’assoluta necessità di allontanarsi dai luoghi comuni “per cercare le parole appropriate che altro non sono, in poesia, se non le tue”. “Ognuno di noi ha il suo porto sepolto dentro di sé: – aggiunge – quando io sprofondo nel mio, le prime parole che mi vengono incontro sono quelle della mia infanzia sul colle e sono la parola ombra, la parola acqua, la parola pietra, la parola muschio, la parola nuvola, la parola fatica, la parola silenzio. […] la parola che preferisco”.
Se volessimo cercare le parole sepolte dentro il porto che Tamaro scava con questo suo libro, potremmo rintracciare le parole neve, gelo, fuoco, terra, cielo, buio, luce, e quella che lei stessa, come Pierluigi Cappello, sembra preferire, silenzio. Consapevole, al pari del poeta, che per chi lo ama e lo pratica il silenzio non esiste, ma è piuttosto quello stato di vuota ricettività interiore che fa percepire ogni battito minimo: della natura, o della propria anima e, perché no, dell’anima di ogni altro vivente. E sassi e rami e foglie, come nella campagna umbra dove Tamaro ha scelto di vivere, o come nel senso traslato degli ultimi versi di Stato di quiete di Cappello, che quasi alla fine del libro la scrittrice riporta con adesione: Costruire una capanna / di sassi rami foglie / un cuore di parole / qui, lontani dal mondo, / al centro delle cose, / nel punto più profondo.
È la capanna metaforica – e nel loro caso talvolta reale, quella di Tricesimo in cui i due scrittori hanno vissuto i momenti della loro intensa amicizia – dove ora Tamaro resta sola, non per demordere ma per ricostruirne un’altra, dove attendere un qualche Angelo della Neve, e lo scricchiolio delle scarpe dell’amico per potersi ricongiungere a lui.
 L’amicizia che Susanna racconta è un’amicizia adulta, giunta tardi attraverso la fascinazione della parola poetica e di quella luce buona e attenta, generosa e radiosa che, come riflesso di un arduo ma mai aspro o domato mestiere di vivere, emanava, in effetti, dallo sguardo di Pierluigi Cappello. Un’amicizia che viaggia su livelli di sensibilità e intensità che attengono più alle categorie dell’eccezionalità che a quelle della routine quotidiana, un rapporto fuori da ogni banalizzazione e da ogni riducibilità. Quasi l’inevitabile confluenza di due persone di età, origine sociale e esperienze diverse, ma che hanno radicato in una serie di coincidenze e in una comune necessità di affrontare un’esistenza tutt’altro che semplice la scintilla che condurrà al tardivo ma folgorante incontro. Per entrambi l’inatteso fulmineo sbriciolarsi della casa di famiglia: sotto le bombe a Trieste la Villa Veneziani degli avi materni di lei, nel disastroso terremoto friulano del maggio 1976 quella di Chiusaforte eretta e faticata dal bisnonno di lui; le scuole a Udine in due Istituti vicini, le stesse piste di atletica sia pure a dieci anni di distanza; un mondo altro che si schiude dalle enciclopedie dell’infanzia; l’esattezza del definire, gemma donata dalla precisione delle Scienze; l’amore e la salvezza offerte dalla lettura, nell’incontro con quei particolari libri che trascinano oltre la quotidianità. E la condizione, infine, che ha relegato entrambi in una situazione di diversità: la mobilità ridotta e la paziente difficile gestione del corpo a cui Cappello è stato costretto da quel fatalissimo incidente e, per Tamaro, le difficoltà e l’angoscia determinate da quella che chiama “la mia invisibile sedia a rotelle, la prigione in cui vivo da quando ho memoria di me stessa”, ossia la sindrome di Asperger, condizione che per la prima volta racconta in questo libro. Come se questa amicizia autentica e fuori da ogni canone, spontanea e libera – liberatoria – sciogliesse i nodi di ogni resistenza e di ogni riserbo, e la spingesse ad accettarsi e finalmente a dirsi con aperta scoperta franchezza. “Provo una stanchezza quasi mortale. – scrive – Sessant’anni di finzione senza essere un attore. I gesti normali delle persone, quelli che vengono compiuti quasi inconsapevolmente, per me sono dei piccoli Everest quotidiani. Conquiste faticose, che avvengono tutte in un riservato silenzio […]. Scoprire, dopo quasi sessant’anni, che la mia sedia a rotelle interiore aveva un nome e che quel nome illuminava tutto ciò che mi aveva tormentato dai tempi dell’asilo è stato il momento più liberatorio della mia vita”.
L’amicizia che Susanna racconta è un’amicizia adulta, giunta tardi attraverso la fascinazione della parola poetica e di quella luce buona e attenta, generosa e radiosa che, come riflesso di un arduo ma mai aspro o domato mestiere di vivere, emanava, in effetti, dallo sguardo di Pierluigi Cappello. Un’amicizia che viaggia su livelli di sensibilità e intensità che attengono più alle categorie dell’eccezionalità che a quelle della routine quotidiana, un rapporto fuori da ogni banalizzazione e da ogni riducibilità. Quasi l’inevitabile confluenza di due persone di età, origine sociale e esperienze diverse, ma che hanno radicato in una serie di coincidenze e in una comune necessità di affrontare un’esistenza tutt’altro che semplice la scintilla che condurrà al tardivo ma folgorante incontro. Per entrambi l’inatteso fulmineo sbriciolarsi della casa di famiglia: sotto le bombe a Trieste la Villa Veneziani degli avi materni di lei, nel disastroso terremoto friulano del maggio 1976 quella di Chiusaforte eretta e faticata dal bisnonno di lui; le scuole a Udine in due Istituti vicini, le stesse piste di atletica sia pure a dieci anni di distanza; un mondo altro che si schiude dalle enciclopedie dell’infanzia; l’esattezza del definire, gemma donata dalla precisione delle Scienze; l’amore e la salvezza offerte dalla lettura, nell’incontro con quei particolari libri che trascinano oltre la quotidianità. E la condizione, infine, che ha relegato entrambi in una situazione di diversità: la mobilità ridotta e la paziente difficile gestione del corpo a cui Cappello è stato costretto da quel fatalissimo incidente e, per Tamaro, le difficoltà e l’angoscia determinate da quella che chiama “la mia invisibile sedia a rotelle, la prigione in cui vivo da quando ho memoria di me stessa”, ossia la sindrome di Asperger, condizione che per la prima volta racconta in questo libro. Come se questa amicizia autentica e fuori da ogni canone, spontanea e libera – liberatoria – sciogliesse i nodi di ogni resistenza e di ogni riserbo, e la spingesse ad accettarsi e finalmente a dirsi con aperta scoperta franchezza. “Provo una stanchezza quasi mortale. – scrive – Sessant’anni di finzione senza essere un attore. I gesti normali delle persone, quelli che vengono compiuti quasi inconsapevolmente, per me sono dei piccoli Everest quotidiani. Conquiste faticose, che avvengono tutte in un riservato silenzio […]. Scoprire, dopo quasi sessant’anni, che la mia sedia a rotelle interiore aveva un nome e che quel nome illuminava tutto ciò che mi aveva tormentato dai tempi dell’asilo è stato il momento più liberatorio della mia vita”.
Una vita che Susanna riprende a raccontare non solo per quanto riguarda la solitudine, la carenza d’amore e il difficile rapporto con i genitori e, più in generale, con l’ambiente circostante nell’infanzia e nell’adolescenza – tutti temi già trattati in Ogni angelo è tremendo– ma per procedere oltre il già noto e il già detto, per riflettere, con sguardo più maturo e distaccato, sull’esistere e sulla realtà in cui si trova/ci troviamo a vivere. Pagine vengono dedicate al nostro tempo veloce, che la scrittrice, sia per scelta sia per necessità determinate dalla sua sindrome, ha ripudiato; a una civiltà viziata di cui non si negano i pregi, ma che nella sua concitazione e nel suo frastuono ha spezzato il ponte con il divino, inteso non in senso confessionale, ma come capacità di soffermarsi sulla bellezza e sulla spiritualità. Altre considerazioni riguardano la forza d’animo, virtù quasi perduta, che è altra cosa dalla forza di carattere a cui si viene invece incitati: distanti tra loro, potremmo dire, quanto l’essere lo è dall’avere. “La forza d’animo – scrive Tamaro – è stata ormai sostituita dalla forza di carattere. Una forza creativa, generosa, inesauribile, capace di gestire le situazioni complesse della vita e un’altra caparbiamente ossessiva nel perseguire il suo obiettivo, non molto diversa da un cane da tana che scava e scava ancora per raggiungere la preda in fondo a un buco”. Quanta forza d’animo occorre, ma anche quanta serena umiltà, quanto ascolto, quanta capacità di vedere la nostra inconsistenza di fronte all’enorme brulicante fabbrica del creato, per orientarsi nell’inevitabile dialettica tra il bene e il male, per trasformare la negatività in positività, per scovare, persino, una possibile fecondità del male, ricercando non tanto o non solo le responsabilità e i colpevoli, ma il modo in cui si può reagire alle sventure.
E infine la necessità del distacco, il comprendere e soprattutto l’accettare che della grande vanitas vanitatum che inscena il teatro del mondo, si è inevitabilmente parte. Scrivere questo libro per Tamaro è stato, come racconta, sfilare l’ultima, più pesante pietra dalla sua gerla, “cercarla nella parte più buia, nascosta tra le foglie”, nella consapevolezza che la fine era la parola “morte”. Scritta accanto al nome di Pierluigi Cappello, ma incombente accanto al nome di ognuno e, per questo, morbido sospingimento dentro una mistica essenzialità: “Eliminare tutto ciò che non serve, raccogliersi, cominciare a respirare in modo diverso, con più calma, con più distacco, come se ci preparassimo a fare un viaggio e cercassimo di conoscere un po’ prima il mondo che ci accoglierà”.
Tutte le virtù che Susanna apprezza e passa al setaccio, Pierluigi le esercitava, aveva dovuto e voluto esercitarle in massimo grado, e questo fa ben comprendere quanto l’aver avuto uno scambio breve ma profondissimo con lui sia considerato, dalla scrittrice, un dono prezioso e inestinguibile. Viene in mente una fulminante sentenza magrisiana: “Amare è un incancellabile infinito presente”. È in questo indelebile infinito verbale che l’esperienza d’amore e la narrazione della scrittrice intendono situarsi. È nell’infinito, sostantivo spaziale, che così Pierluigi Cappello, negli ultimi versi scritti sul suo taccuino, intravede:
[…] restano le pietre, pulite, bianche di sole
e il sentiero che sale e, in cima piega a una svolta
e non c’è modo di vedere cosa c’è al di là
perché tu sei in basso e la salita in alto;
ma quello che vedi oltre
l’orlo del tracciato è un vuoto
di colore, che lontano si fa giallino
e più lontano ancora
un infinito tutto e una gioia senza direzione.
Susanna Tamaro
Il tuo sguardo illumina il mondo
Solferino, Milano, 2018
Pierluigi Cappello
Un prato in pendio
Tutte le poesie 1992-2017 e ultimi inediti
Rizzoli, Milano, 2018